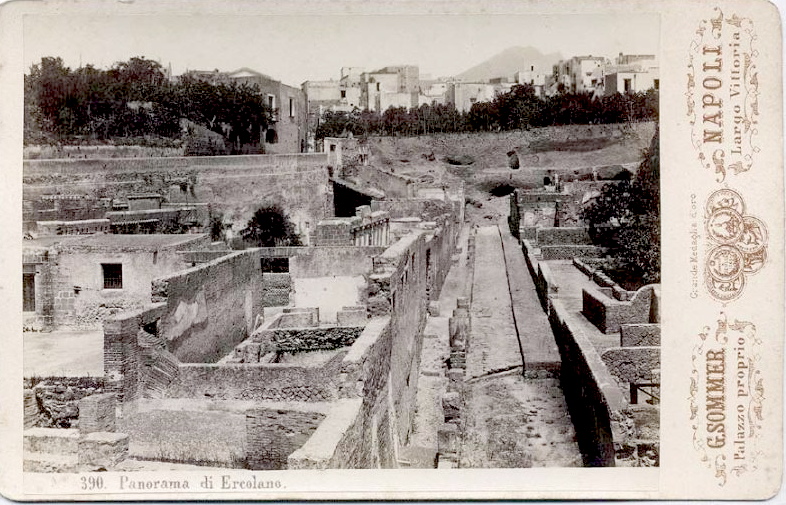Le scoperte di Ercolano ebbero sin dal principio una grande risonanza negli
ambienti antiquari italiani ed europei che si mostrarono curiosi e desiderosi
di reperire quante più notizie possibili su ciò che andava rinvenendosi. La
collezione archeologica del re delle Due Sicilie si avviava a diventare
unica nel suo genere e ciò attirava inevitabilmente le attenzioni di studiosi,
eruditi, antiquari e collezionisti. Per questo, mentre gli scavi avanzavano,
si apriva una vera e propria caccia al reperto; si assisteva ad un
collezionismo clandestino con un collegato, attivissimo, traffico di reperti
archeologici. Si alimentò un ampio mercato che, sull’onda dell’interesse
suscitato dallo scavo ercolanese, raggiunse considerevoli dimensioni.
Per una fase abbastanza lunga fu alquanto agevole trovare pezzi di vario
genere ed esportarli fuori dei confini del Regno. In assenza di una
legislazione che salvaguardasse il patrimonio artistico archeologico, aveva
gioco facile il collezionismo clandestino che non incontrava difficoltà nel
reperimento e nella circolazione di oggetti antichi. Costituisce un chiaro
esempio di questa situazione proprio la vicenda del principe d’Elbeuf che,
senza incontrare difficoltà di sorta, potè esportare gran parte del materiale
recuperato nel sito ercolanese, soprattutto verso l’Austria. Il percorso dei
reperti ritrovati dal principe prevedeva una tappa intermedia a Roma, dove
si provvedeva al restauro; una volta completato questo gli oggetti erano
pronti ad essere trasferiti all’estero. Ma nella città eterna tale esportazione
andava a confliggere con la normativa dello Stato Pontificio che, in virtù
del gran numero di tesori archeologici posseduti, aveva già emanato alcuni
testi legislativi a tutela dal patrimonio storico culturale. Nel momento in cui
gli oggetti restaurati lasciavano Roma, nel caso specifico per raggiungere
l’Austria, si assisteva ad una violazione delle norme che vietavano
l’esportazione al di fuori dello Stato di oggetti dal particolare valore storico
artistico e culturale. L’aggiramento, da parte del principe, di tali divieti,
valse le proteste delle autorità pontificie nei confronti del viceregno
austriaco di Napoli che rispose però in modo blando, manifestando il
proprio disinteresse e non cogliendo l’occasione o lo spunto per avviare un
percorso legislativo che avrebbe adeguato il quadro normativo
all’importanza del patrimonio napoletano. Ma nel viceregno napoletano il
vuoto legislativo in materia di tutela di beni culturali nazionali dispiegava i
suoi effetti non solo nei riguardi dei tesori archeologici ma anche in
relazione ad altre categorie di beni, come testimoniato dalla vicenda
dell’esportazione a Vienna di antichi codici conservati nella Biblioteca di
San Giovanni a Carbonara e dalla dispersione della preziosa e variegata
collezione del giurista Valletta ad opera degli eredi.

Con l’avvento dei Borbone e nonostante l’inizio dell’impresa archeologica
ufficiale le cose non cambiarono di molto; solo si impedì, attraverso
un’attenta vigilanza, il depredamento nelle zone dello scavo reale. Furono ordinati rigidi controlli, soprattutto sugli addetti materialmente allo scavo e
sanzioni pesanti furono previste per chi si fosse macchiato del reato di furto
dei reperti archeologici. Si utilizzò inoltre il metodo della distruzione del
materiale non idoneo ad essere trasportato nel Museo Ercolanese, al fine di
non esporlo al trafugamento o alla copia; soluzione primitiva e dannosa,
segno dell’iniziale difficoltà di strutturare una politica culturale e di tutela
coerente. Un episodio del 1740, conclusosi con l’arresto e la punizione
esemplare di cinque persone è emblematico per illustrare come la corte si
comportò, intendendo anche dare un segnale ad eventuali malintenzionati.
Si tratta del furto di alcuni oggetti antichi che tali cinque persone avevano
compiuto nel 1740; scoperti, furono sottoposti a tortura, confessarono il
reato e l’8 dicembre 1740 il re approvò la sentenza nella quale si prevedeva
l’incarcerazione per due degli uomini a due e tre anni di galera, oltre che la
punizione corporale della frusta; alle due donne fu imposto l’esilio per tre
anni. E’ palese l’intento dimostrativo che si volle perseguire attraverso
questo intervento deciso ed autoritario. Fu in seguito a questa vicenda che i
controlli risultarono intensificati con l’emanazione di un regolamento più
rigido. L’intervento del potere centrale sembra essere stato incisivo dal
momento che non vi sono notizie di furti nella zona pubblica di scavo dopo
il 1740 anche se, essendo la fonte governativa, non si può esserne certi. Il
re aveva usato il pugno duro per difendere ciò che considerava di sua
esclusiva proprietà; siamo ancora di fronte ad un tentativo di difesa della proprietà privata del re e non di un bene pubblico bisognoso di protezione
in quanto tale.
Altra questione collegata e rilevante era quella dei falsi che prendevano a
circolare nel mercato. La corte si ritrovò a combattere anche questo
problema e dovette talvolta ricorrere a soluzioni decise, come nel caso dei
falsi messi in circolazione dal pittore romano Guerra 8 . Il problema dei falsi
nasceva dalla grandissima richiesta di cui godevano le antichità ercolanesi,
che erano ormai diventate protagoniste indiscusse del mercato nero di
reperti archeologici.
Messe al riparo le operazioni di scavo reale dai malintenzionati, restava
ancora difficile da realizzare il controllo, quantomeno di soprintendenza,
sulle attività private di scavo che fiorivano sempre più velocemente, spesso
condotte da personaggi di modesta statura culturale e con poca o nulla
conoscenza antiquaria, alimentando il mercato. Restava ancora difficile
immaginare, alla luce delle concezioni prevalenti nella corte, una tutela
efficace per i beni che non avessero diretta rilevanza ai fini
dell’arricchimento delle collezioni reali. Non si era ancora raggiunta la
consapevolezza necessaria per ritenere tutto ciò che arricchiva il Regno
quale bene pubblico da proteggere in virtù dell’interesse del popolo per il
territorio nazionale. In effetti, registrata l’assenza di norme interne che
sancivano divieti o prevedevano controlli, tali attività private non potevano
qualificarsi come illecite, non andando a violare alcuna norma vigente.
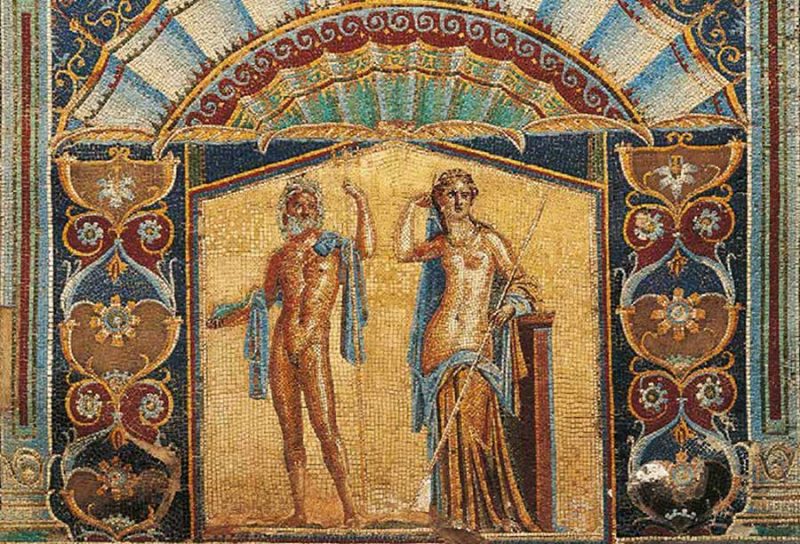
Nessuna autorizzazione era necessaria per intraprendere un’attività di scavo
ed era oggettivamente difficile predisporre un apparato in grado di
controllare effettivamente tutto il vasto territorio del Regno. Ad ogni modo, il Guerra aveva diffuso a Roma dei falsi di alcuni reperti ercolanesi. La corte smascherò l’inganno acquistando i falsi ed esponendoli accanto agli originali evidenziandone efficacemente la palese differenza.
Il più grave problema che poneva lo scavo privato non stava tanto nel
criterio di archeologia finalizzata esclusivamente all’acquisizione del
reperto, dal momento che questa era la linea seguita anche dallo scavo
ufficiale. Il vero punto critico stava nella circolazione clandestina del
reperto, che era stimolata da queste attività di ricerca private. Fioriva
l’esportazione di oggetti di rilevanza storica culturale dal Regno, che
andavano ad arricchire le collezioni private in giro per l’Europa.
La situazione era delicata e stimolava dibattiti e proposte per arginare il
fenomeno. Una proposta lucida ed anticipatrice provenne dallo scultore
Canart e risale al 1751; egli sostenne la necessità di predisporre una
normativa che controllasse adeguatamente le attività di scavo private, da
effettuarsi solo previa autorizzazione, e limitasse sensibilmente
l’esportazione indiscriminata dei tesori archeologici del Regno;
individuando con precisione i settori d’intervento e indicando come
modello il sistema di tutela nello Stato Pontificio, la proposta del Canart si
presenta come “ intervento assai incisivo […] ed improntato ad un
atteggiamento pragmatico che, lungi dall’esaurirsi in sterili quanto
generiche deplorazioni dello status quo, si dirige al concreto delle questioni
e alla sostanza dei possibili rimedi, additando soluzioni percorribili e già
sperimentate” a Roma.

Sulla scorta di una serie di opinioni in questo senso e sulla base di una
accresciuta sensibilità e consapevolezza dell’importanza del patrimonio
archeologico, incredibilmente arricchitosi con gli scavi ercolanesi, il re
intervenne per via legislativa. La prammatica del 1755 segna il punto
d’arrivo di un percorso di acquisizione di consapevolezza e di
responsabilizzazione nei confronti delle ricchezze artistiche archeologiche del Regno, e allo stesso tempo rappresenta la base da cui si sarebbe
sviluppata e perfezionata la politica di tutela dei beni culturali, che
avrebbero perso con il tempo la connotazione di beni personalissimi del
sovrano per essere considerati quale bene pubblico, la cui tutela era
doverosamente compito dello Stato, in nome del pubblico interesse alla
salvaguardia del patrimonio storico e culturale nazionale. La strada
sarebbe stata lunga ma la normativa napoletana si presenta quale elemento
innovativo nei contenuti ed emblematico della sensibilità di Carlo di
Borbone riguardo al tema della tutela dello straordinario patrimonio del
Regno.